Diamola per letta
Libri vecchi e nuovi che parlano di processi (famosi e non) e, in senso ampio, del processo penale.
Li abbiamo letti per voi. Ecco quello che ne pensiamo.
A cura di Alessandro Brustia

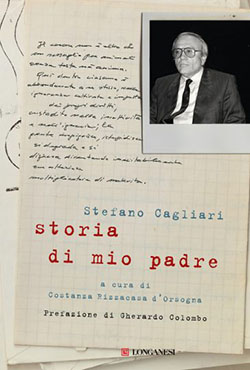 Storia di mio padre
Storia di mio padre
Stefano Cagliari.
“Guai a quel paese che affida le lotte politiche alle aule dei tribunali e i processi ai moti di piazza e a un’opinione pubblica costruita dai media il cui scopo primario è vendere entrando in ogni settore e sostituendo ogni altra voce”.
Procure che perseguono finalità politico sociali, anziché prettamente giudiziarie, processi mediatici e sommari che condizionano un’opinione pubblica facilmente influenzabile. Era il 1993, non c’era internet né i social network, eppure Gabriele Cagliari, Presidente dell’Eni, da mesi in custodia cautelare in carcere a San Vittore, avrebbe potuto scrivere le stesse cose oggi, 25 anni dopo, se nel frattempo non si fosse suicidato in carcere.
E’ solo uno dei tanti spunti di questo bellissimo libro scritto da Stefano Cagliari, figlio di Gabriele, cioè di uno dei protagonisti della triste e drammatica vicenda di Mani Pulite: arrestato il 9.3.1993 su richiesta della Procura di Milano, rimase a San Vittore per più di 4 mesi. Fu trovato morto il 20.7.1993 nelle docce del carcere. Era al secondo tentativo di suicidio.
Nel libro il figlio racconta la vicenda del padre traendo spunto dalle lettere e dalle poesie che egli scriveva, comprese quelle inviate al suo difensore, ai figli e alla moglie, in cui spiegava con inquietante lucidità le ragioni del suo gesto.
Nei suoi scritti Cagliari denuncia l’uso della custodia cautelare come mezzo di pressione per ottenere informazioni e confessioni, e le condizioni drammatiche del carcere. Al lettore di più di 30 anni dopo tutto questo suonerà terribilmente attuale, in un momento in cui la politica punta in modo miope su un sistema sempre più carcerocentrico e grida allo scandalo non appena si voglia mettere mano, per esempio, a una riforma dell’ordinamento penitenziario in linea con i dettami della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Vi sarebbe poi da discutere sugli effetti distorti di quella stagione, che fu, com’era dichiaratamente nelle intenzioni, “una rivoluzione” ma che, come tale, lasciò dietro di sé anche lunghe scie di dolore e, come nel caso di Cagliari, di suicidi. Questa però è una riflessione da lasciare alla storia, nell’auspicio che la distanza dai fatti ne favorisca una visione priva di condizionamenti e finalmente oggettiva.
Approfondimento
www.gabrielecagliari.it
 Il corpo del reato
Il corpo del reato
Carlo Bonini.
Cosa succede quando lo Stato tratta i cittadini come sudditi, quando i suoi servitori ritengono di essere al di sopra delle leggi e pensano di potersi rapportare a un cittadino loro pari come se, invece, fosse un essere inferiore, da punire prima ancora (e con mezzi ben più convincenti!) che intervenga la giustizia, con la sua lenta e farraginosa macchina?
E’ l’interrogativo di fondo al quale cerca di rispondere l’autore di questo libro, ripercorrendo dettagliatamente la storia del c.d. caso Cucchi, uno dei più recenti ed eclatanti casi di “tortura italiana”, - casi che hanno tanto interessato l’opinione pubblica senza però portare la Repubblica ad avere una legge sulla tortura degna di questo nome, (“perché altrimenti si impedisce alla polizia di agire liberamente” chiosano gli illuminati politici nostrani, commettendo un clamoroso autogol).
E’ il 15 ottobre 2009 quando Stefano Cucchi, dopo aver trascorso il pomeriggio in palestra ad allenarsi, viene arrestato mentre cede droga a una terza persona. I genitori lo vedranno a casa di lì a qualche ora, accompagnato dai Carabinieri intenti nella perquisizione domiciliare. Nonostante le ricerche la famiglia non ne avrà alcuna altra notizia finché – incredibile!- 5 giorni dopo non sarà notificato l’avviso di espletamento dell’autopsia.
Cosa gli sia successo, nel frattempo, e quali siano le cause e le responsabilità della morte lo spiega nei particolari il libro, avvincente come un giallo ma, purtroppo, tutt’altro che frutto della fantasia. Il punto di partenza è che il cadavere Cucchi ha due vertebre rotte, ma per arrivare a stabilirlo ci vorranno anni di lotte e ben 4 consulenze.
Va detto che un giudizio complessivo sulla vicenda, a distanza di 9 anni, è tuttora prematuro, visto che davanti al Tribunale di Roma è in corso il c.d. processo Cucchi bis nei confronti dei tre Carabinieri che quella sera arrestarono il geometra romano e che, fino ad ora, non erano stati coinvolti dalle indagini (mentre poliziotti penitenziari e medici sono stati tutti assolti). E’ comunque utile capire gli enormi sforzi fatti dalla difesa di Cucchi e, a monte, dalla sua famiglia, per combattere contro la chiusura ermetica di uno Stato preoccupato più di difendere i propri oscuri apparati burocratici che di accertare la responsabilità della morte atroce di un cittadino.
L’auspicio, tuttavia, è che, al di là degli esiti giudiziari, il caso – e libri come questo – possa portare a una presa di coscienza da parte dell’opinione pubblica. Senza tanti giri di parole, il prossimo Stefano Cucchi o Federico Aldrovandi potrebbe essere chiunque di noi. Basterebbe capire che lo Stato di Diritto è un bene da salvaguardare preziosamente. In tempi come questi, in cui navighiamo a vista tra violenza, razzismo e giustizialismo, è un ottimismo che fa davvero sorridere, ce ne rendiamo conto.
 Ho visto l'uomo nero
Ho visto l'uomo nero
Claudio Cerasa.
La storia delle aberrazioni del processo mediatico è lunga e costellata da episodi eclatanti. Dal momento che, come si vede tutti i giorni, la questione è quanto mai scottante non è inutile ripercorrere alcuni di questi episodi e capire da dove si sia partiti per arrivare alla drammatica situazione attuale.
In questo libro l’attuale direttore del Foglio, Claudio Cerasa (una delle poche voci che coraggiosamente si battono contro il giustizialismo esasperato dei media italiani), racconta dei celeberrimi fatti di Rignano Flaminio. Lo stile è quello del reportage giornalistico, accurato e dettagliatissimo.
I fatti sono noti: nella primavera del 2006 i Carabinieri di quel placido paesino ricevono le prime denunce circa gli abusi che quelli che di lì a poco sarebbero stati linciati pubblicamente come “mostri” e “orchi” avrebbero commesso su 21 bambini del locale asilo. Si tratta di alcune maestre, una bidella e altre persone che abitano in paese, tutte coinvolte in un vorticoso e violentissimo giro di messe sataniche.
La vicenda assumerà contorni tristemente grotteschi di lì a un anno quando gli indagati saranno arrestati per (tra l’altro) associazione a delinquere finalizzata al compimento di violenze sessuali su minori; a questo punto i fatti, doverosamente amplificati dalla grancassa dei media, diverranno noti al pubblico. Sul sito de “il Foglio” sono riportati alcuni titoli dei giornali dell’epoca. Eccone alcuni: “Quei pedofili ogni domenica a Messa” “I bimbi dell’asilo <
Il resto è storia giudiziaria. Tutti gli imputati saranno assolti perché il fatto non sussiste ma soltanto dopo lunghissimi anni di sofferenze (il processo è stato definito soltanto nel 2014).
Una vicenda ben ricostruita dal libro e che avrebbe dovuto insegnare molto a tutti, operatori del diritto, opinione pubblica e media.
Se sia servito o meno non è nemmeno il caso di dirlo.
 Io, trafficante di virus
Io, trafficante di virus
Ilaria Capua.
Nel 2014 Ilaria Capua ha una bella famiglia ed è all’apice della carriera: scienziata di fama mondiale, insignita di prestigiosi premi per la sua attività come virologa, è una donna fiera di essersi affermata in un mondo prettamente maschile ed è l’orgoglio della comunità scientifica italiana. Non solo, alle elezioni del 2013 si candida e diviene deputata perché vuole provare in prima persona a cambiare un paese in cui si ostina a credere.
Cosa può capitarle?
Quello che può capitare a qualsiasi persona, di essere stritolato nella morsa terribile di un processo mediatico. Una specie di fake news elevata al rango di procedimento penale.
Infatti un giorno l’Espresso esce con uno scoop sensazionale, intitolato “trafficanti di virus” in cui si racconta, corredando il servizio con tanto di stralci di intercettazioni, di una indagine della Procura di Roma su un’associazione a delinquere, di cui lei farebbe parte, dedita, tra le altre cose, a un traffico illegale di virus che sarebbero immessi negli allevamenti animali allo scopo di creare epidemie sulle quali poi intervenire lucrando sui vaccini e i medicinali: un’accusa infamante per una scienziata, una manna per i sempre più numerosi complottisti e i dietrologi in servizio effettivo permanente.
Lei, la più illustre virologa italiana, in pratica è indagata per tentata strage senza saperlo e viene trascinata in un incubo nel quale non si capisce quali siano le accuse e come difendersi prima fuori che dentro i tribunali, per resistere a una pressione mediatica che tutto travolge e non si cura della verità o della verosimiglianza delle accuse, ma soltanto della loro portata sensazionalistica e roviniosa.
Tant’è. Volente o nolente Ilaria Capua deve difendersi e lo fa con le unghie per lunghi anni. E di anni ce ne vogliono ben 3 prima di arrivare davanti a un Giudice per l’udienza preliminare che, grazie a Dio, smonta una per una tutte le accuse, emettendo sentenza di non doversi procedere nei suoi confronti. Il tutto era basato su fraintendimenti di frasi intercettati (per esempio, l’indicazione di un centro di costo a bilancio era scambiato con il nome in codice per indicare una società offshore) e banalissimi errori nell’analisi dei dati scientifici. “Ci scusi, dottoressa, ci siamo sbagliati”.
Nel frattempo però lei – che rifiuta categoricamente di essere definita “cervello in fuga” – è stata sostanzialmente espulsa da un paese nel quale vige il giustizialismo più bieco e, a tutti i livelli (parlamentare, scientifico...), l’indagato è un appestato da evitare: ha quindi accettato di emigrare in Florida e dirigere là, lontana dal paese che voleva cambiare, un prestigioso centro di ricerca.
In questo libro Ilaria Capua racconta la sua terribile storia accendendo un faro, contemporaneamente, su una serie indefinita di problemi: le storture del processo mediatico, la potenzia distruttrice di un’indagine basata su errori macroscopici e intercettazioni fraintese, la difficoltà di fare ricerca in Italia. E’ vero, il sistema ha funzionato: al primo vaglio di un Giudice le accuse si sono sciolte come neve al sole. Non è quindi tecnicamente possibile parlare di errore giudiziario: ma il danno era già stato fatto, e a quale prezzo si è arrivati a quella sentenza? Al prezzo di avere quasi distrutto un essere umano e sottratto al paese una risorsa importantissima dal punto di vista scientifico e politico.
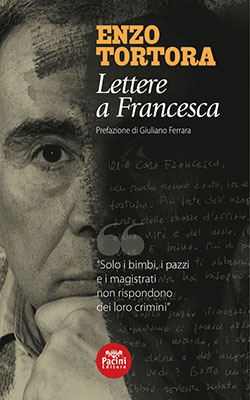 Lettere a Francesca
Lettere a Francesca
Enzo Tortora.
Grazie alla collaborazione tra l’ex senatrice Francesca Scopelliti, la Fondazione Enzo Tortora e l’Unione Camere Penali sono pubblicate, in questo bellissimo volumetto, le lettere che Enzo Tortora scrisse alla sua compagna dal carcere nei lunghi mesi di carcerazione preventiva, quando lui, da volto amico nelle case di tutti gli italiani, si era trasformato per l’opinione pubblica (opportunamente sobillata da una pressione mediatica senza precedenti) in un “cinico mercante di morte”.
Il caso, che nella storia italiana recente costituisce il più clamoroso “errore” giudiziario (dove le virgolette indicano l’inadeguatezza di un termine che forse andrebbe modificato in crimine, come ribadisce la senatrice Scopelliti), è noto a tutti ma non fa male farne un ripasso guidati, “da dentro”, dalle parole di chi subì quella barbarie. E così di Tortora si scopre un lato forse poco conosciuto, quello della sua cultura profondissima, che gli consente di interrogarsi, a volte disperatamente, non solo sull’assurdità delle accuse che gli sono mosse ma anche sull’incoerenza di un sistema che abusa della misura cautelare per malcelati scopi mediatici e che non si fa remore a infliggere ai detenuti condizioni inumane.
La raccolta di lettere alterna momenti di ribellione a momenti di intimo amore per la compagna, che quasi si ha imbarazzo a scoprire; particolarmente emozionanti sono poi le lettere in cui Tortora mostra una determinazione feroce nel voler lottare, fino all’ultimo, per far emergere la propria innocenza.
Insomma una denuncia delle condizioni del carcere e dei detenuti e un grido di dolore sullo stato della giustizia e sulla gogna mediatica (o di Stato?) che qualsiasi malcapitato può trovarsi a subire come la subì Tortora. Sembrano parole scritte ieri, invece sono passati 33 anni in cui, tra l’altro, è entrato in vigore un codice di procedura penale nuovo che avrebbe, in teoria, dovuto comportare un cambiamento radicale (sappiamo che così non è stato). La lezione però è sempre attuale, anzi sempre più attuale e ci ricorda che le conquiste di civiltà devono essere sudate tutti i giorni, nelle aule di tribunale e nella difesa degli imputati eccellenti come degli ultimi, e per ribadire con forza e fermezza che i diritti dell’imputato vengono prima di tutto, prima della rapidità dei processi e dell’efficientismo: ricordiamo spesso che l’abolizione dell’appello, più volte ipotizzata, avrebbe portato Tortora a morire da colpevole, ma vi è di più.
Per fare un esempio ancora più calato nella realtà dei giorni nostri, se, nell’ambito della riforma Orlando passasse la normativa sul processo a distanza e i detenuti fossero costretti a difendersi lontano dall’aula, senza il difensore al proprio fianco e sedendo in un angusto ufficio anziché nell’aula in cui si amministra la giustizia “in nome del popolo italiano”, il prossimo Enzo Tortora – e ce ne sono, e ce ne saranno! – non potrebbe sfidare i propri giudici dicendo loro in faccia, a muso duro: “io sono innocente. Spero lo siate anche voi”.
Un libro che dovrebbe essere letto dai tecnici ma soprattutto dai cittadini, a partire dai giovani, nella speranza, in questi tempi particolarmente duri per le istanze garantistiche e di libertà, di formare un’opinione pubblica in grado di giudicare con spirito critico e meno influenzato dal clamore mediatico.
Un’esortazione a non arretrare mai, nemmeno di un centimetro, sul piano dei diritti individuali, perché lo Stato resti, soprattutto, uno stato di diritto.
 Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla
Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla
Gherardo Colombo.
Gherardo Colombo è uno dei celeberrimi magistrati del pool di Mani Pulite che, dal 1992 in poi sconvolse l’Italia e il suo sistema economico e politico. In quegli anni di persone in carcere ne mandò tante e non stiamo a rivangare se fosse sempre necessario. La storia sta già dando la sua risposta. Di fatto, per quel che qui interessa, il dr. Colombo riteneva la carcerazione, preventiva o meno, uno strumento utile, dal suo punto di vista.
Ebbene, ha cambiato idea.
Ha lasciato la magistratura con ampio anticipo sui tempi di pensionamento ed ha avviato quella che sembrerebbe essere una profonda riflessione personale: si dedica a parlare di rispetto delle regole e di educazione alla legalità nelle scuole (esattamente come noi, suoi antichi “avversari”) – www.sulleregole.it – e scrive libri, come questo, in cui cerca di spiegare coraggiosamente – in una società fortemente permeata da un giustizialismo, spesso miope e becero – che il regime carcerario non serve a nulla se non a infliggere una sofferenza inutile attraverso la “vendetta di stato”: se a male si risponde col male, alla fine il risultato non è un’assenza di male, ma una somma, anzi una moltiplicazione, di mali.
Infatti è proprio dal fallimento totale del modello della giustizia retributiva che prende le mosse l’autore, sottolineando profusamente – sulla scia di illustri predecessori, Wiesnet in primis – come si tratti di un sistema che abbandona non solo il colpevole, neutralizzato e privato di qualsiasi possibilità di rieducazione e reinserimento nella società, ma anche la vittima, cioè proprio la persona alla quale si vorrebbe dichiaratamente garantire una tutela più forte ed efficace. Di fatto, una volta celebrato il processo e rinchiuso legalmente il colpevole in carcere per anni, alla vittima cosa resta, al di là di un’effimera vendetta, della quale apprezza ben presto l’inutilità?
Al contrario, nel modello di giustizia riparativa abbracciato da Colombo, è la società a farsi carico – attraverso strumenti come la mediazione – di riavvicinare vittima e colpevole, di aiutare quest’ultimo ad assumersi in piena consapevolezza la responsabilità della sua condotta e di consentirgli, a patto che non sia pericoloso e che voglia riabilitarsi, un percorso rieducativo cosciente ed efficace.
Di qui l’esegesi del titolo: a chi si macchia di reati la società deve necessariamente garantire un perdono, non scontato, non aprioristico, ma che presupponga una volontà di riabilitazione e che sia strettamente finalizzato, secondo il paradigma costituzionale, a una riconquista del reo alla società. Servirà a poco, temiamo, ma il dato confortante è che simili riflessioni scaturiscano da una penna così autorevole e, un tempo, attestata su ben altre posizioni.
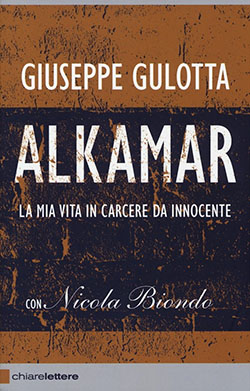 Alkamar. La mia vita in carcere da innocente
Alkamar. La mia vita in carcere da innocente
Giuseppe Gulotta, con Nicola Biondo.
Faceva il muratore e aveva 18 anni Giuseppe Gulotta quando fu arrestato per l’omicidio di due carabinieri nella caserma Alkamar di Alcamo Marina. Ne aveva 56 il 13.2.2012 quando fu definitivamente scagionato da quella terribile accusa. Ne aveva passati 22 in carcere. Un periodo di vita durante il quale gli esseri umani prima costruiscono il proprio futuro, studiano, lavorano, magari mettono su famiglia o semplicemente si perdono per il mondo. Giuseppe Gulotta no. Giuseppe Gulotta ha trascorso la parte migliore della sua vita in carcere, con il marchio infamante – con il crisma della definitività - di avere ucciso due carabinieri.
Era il 27 gennaio del 1976: le indagini dapprima si mossero nella direzione del terrorismo rosso, poi ipotizzando un coinvolgimento della mafia. Infine, il 12 febbraio 1976, si arrivò alla piena, tranquillizzante ed esaustiva confessione di 4 ragazzi di Alcamo Marina e dintorni. Poco importa se, dal giorno dopo, tutti e quattro incominciarono a raccontare delle torture subite dai Carabinieri per confessare: lunghe ore di finte esecuzioni con la pistola, schiaffi, sputi. Poco importa. Quello che conta era avere il delitto perfetto: un innocente in carcere a fare da capro espiatorio e il colpevole libero e impunito.
La terribile storia di Giuseppe Gulotta, raccontata in questo libro, è tornata alla ribalta delle cronache dopo che lo Stato gli ha garantito, bontà sua, un risarcimento del danno di 6,5 milioni di euro (che saranno pagati dai contribuenti, beninteso, non dai torturatori o dai magistrati che si occuparono della vicenda). E’una storia che vale la pena di rileggere per capire come il Leviathano della giustizia di stato possa, ancora oggi, stritolare, masticare e sputare l’esistenza di un essere umano. E’ bene non dimenticarlo, proprio nei giorni in cui il Presidente dell’ANM critica apertamente il fatto che a dibattimento debbano essere “risentiti i testimoni che sono già stati sentiti dai Carabinieri nel corso delle indagini”, che il dubbio è la regola che deve sempre guidare gli operatori del diritto (per l’opinione pubblica, invece, non c’è speranza). Non si tratta solo dell’eventualità dell’errore giudiziario (perché nel caso di Gulotta sembra quasi offensivo parlare di errore giudiziario): quanti Giuseppe Gulotta ci sono attualmente tra le decine di migliaia di detenuti nelle carceri italiane?
Oggi Giuseppe Gulotta è un uomo libero, finalmente. Cercando su you tube si trova un video in cui passeggia in riva al mare della sua Alcamo, un mare bellissimo che contrasta drammaticamente con il suo sorriso triste.
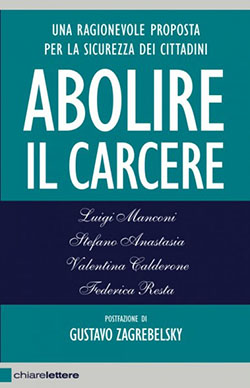 Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini
Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini
Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone, Federica Resta.
“Più penso ai problemi del carcere più mi convinco che la riforma carceraria da effettuare è quella di abolire il carcere penale e sostituirlo con un luogo dove sia possibile una vita normale, controllata da magistrati, con possibilità di guadagnare, di sposarsi, di aver casa, di vivere civilmente”. Così scriveva Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell’Unione Europea, in una lettera indirizzata nel 1945 a Piero Calamandrei. E’ dunque di nobile schiatta il c.d. movimento abolizionista (del carcere) che trova in questo breve pamphlet il suo manifesto programmatico.
Contrariamente a quanto possa sembrare non si tratta di una provocazione ma di uno studio rigoroso con il quale, dati alla mano, gli autori dimostrano come fare a meno del carcere si possa e si debba. Del resto in Italia l’82,6% dei condannati sconta la pena in carcere mentre in Francia e Gran Bretagna (ad onta di quanto spesso viene propinato all’opinione pubblica) soltanto il 24%.
Non solo. L’idea del carcere non è ineluttabile né immanente alla storia dell’umanità. Tutt’altro: nella sua declinazione attuale è un’invenzione relativamente recente (diciottesimo secolo); che poi dia risultati pessimi se rapportati all’ambizioso paradigma dell’art. 27 della Costituzione in ordine alla finalità rieducativa della pena è un dato sul quale soltanto chi è animato da malafede può seriamente discutere: basti ricordare il tasso di recidiva di chi sconta la pena in carcere (68%) confrontato con chi, invece, la sconta con una pena alternativa (20%).
Si è anche calcolato, con uno studio che non fa che confermare ciò che ogni penalista sa bene, che la percentuale dei detenuti veramente pericolosi (omicidi, trafficanti di droga etc.) si attesta intorno al 10% della popolazione carceraria.
Pertanto fare a meno del carcere, termine che nemmeno compare nella Costituzione (che parla genericamente di pene, non aggettivandole), si può. Del resto qualche timido spiraglio si è già avuto, con l’introduzione recente di una serie di istituti quali la detenzione domiciliare, la messa alla prova, la particolare tenuità del fatto etc.
Ecco allora la ricetta degli autori, declinata in un decalogo di riforme, tra cui l’abolizione del carcere, dell’ergastolo (definita da Papa Bergoglio “pena di morte occulta”), del carcere femminile, la mediazione e altri istituti maggiormente flessibili e “personalizzabili” rispetto all’ottusa rigidità del carcere, risposta statale assurdamente identica per il ladro di polli, per il terrorista e per il boss mafioso.
In definitiva una proposta interessantissima e molto meno utopica di quanto appaia di primo acchito ma che, come correttamente ritenuto dagli autori, ha speranza di fare breccia soltanto qualora si diffonda la conoscenza della realtà carceraria. Solo chi non conosce il carcere (e l’opinione pubblica di sicuro non lo conosce) e le sue storture (per esempio l’alto tasso di suicidi non solo tra i detenuti ma anche tra i poliziotti penitenziari) può augurarlo agli altri e ritenerlo un metodo efficace per garantire la sicurezza della società.
 Gridavano e piangevano. La tortura in Italia. Ciò che ci insegna Bolzaneto
Gridavano e piangevano. La tortura in Italia. Ciò che ci insegna Bolzaneto
Roberto Settembre
Inquietudine, disgusto e vergogna. Soprattutto tanta vergogna. Queste sono le sensazioni ricorrenti nella lettura di questo libro non bello dal punto di vista strettamente tecnico - letterario, ma necessario, assolutamente necessario. A scriverlo è Roberto Settembre, uno dei magistrati che ha composto il Collegio dell’Appello del processo per i fatti occorsi alla caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001.
Un libro che, prendendo le mosse dai verbali delle deposizioni delle persone, italiane e straniere, arrestate e seviziate per ore e ore presso la Caserma di Bolzaneto, non risparmia nulla delle torture subite da quelle persone, che l’autore definisce “prigionieri” (per buona parte del tutto innocenti rispetto alle devastazioni subite dalla città, se a qualcosa vale la precisazione): centinaia di persone (uomini e donne, giovani e meno) derise, umiliate, picchiate selvaggiamente e vigliaccamente, private di tutto a partire dalla dignità (molte persone costrette a fare flessioni nudi o a farsela addosso, tanto per esemplificare). Il tutto per giorni interi in una situazione di completa sospensione dei diritti civili e dello Stato di diritto.
Così la lettura delle torture diventa una tortura essa stessa, e quasi si arriva a detestare l’autore che, in modo volutamente asettico, indulge però nei particolari (il sangue, il vomito…) e sempre domina la vergogna per quello che è stato commesso da persone che rappresentavano lo Stato. Non in Cile, in Messico o in Cambogia. In Italia, a Genova. A casa nostra. Una delle pagine più brutte della nostra giovane Nazione.
Un libro da leggere per non dimenticare e che rimarca la scandalosa inerzia italiana nell’introdurre nell’ordinamento il reato di tortura a 32 anni dalla Convenzione ONU contro la tortura del 1984 e a quasi un anno dalla severissima condanna inflitta dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo proprio per i fatti di Genova (condanna motivata sia da quanto accaduto sia dalla mancata previsione del reato di tortura all’interno dell’ordinamento).
In un paese che soffre di elefantiasi normativa, che sull’onda emotiva di fatti di cronaca non perde occasione per introdurre reati giuridicamente dissennati, inutili e disorganici come l’immigrazione clandestina e come l’omicidio stradale (per fare esempi recenti)non si introduce l’unico reato che si dovrebbe (per espresso monito della Corte CEDU) e avrebbe senso prevedere, come in tanti altri stati europei (Inghilterra, Francia, Spagna etc).
Perché? Molto semplice: perché non porta voti, anzi, ne fa probabilmente perdere.
E questo ci porta a un’ulteriore considerazione. Se la politica non si decide, anzi palesemente tergiversa per non rischiare di essere impopolare, allora significa che nell’opinione pubblica non si sente alcuna necessità di una norma del genere perché, agli occhi dell’uomo della strada, la giustizia non funziona e non punisce a sufficienza e allora meglio delegare la sanzione a un poliziotto dalle mani pesanti, meglio girarsi dall’altra parte a fronte dei piccoli e grandi soprusi quotidiani delle forze dell’ordine (nonostante il caso Cucchi, nonostante il caso Uva, nonostante tutto), perché tutto sommato “se li menano allora se lo saranno meritato”.
Di qui l’amara ma inevitabile conclusione: l’introduzione del reato di tortura è necessaria ma non basta. Come per qualsiasi altro fenomeno sociale (maltrattamenti in famiglia, circolazione stradale…), la legge, più o meno draconiana, deve discendere da un sostrato sociale concreto, deve essere condivisa dalla comunità e percepita come giusta. Ecco, si deve operare a livello di società, di cultura dei diritti civili e delle libertà politiche. Perché lo stato di diritto non debba più vivere notti buie come quelle di Genova.
 Fine pena: ora
Fine pena: ora
Elvio Fassone
Un lungo e complicato processo di criminalità organizzata in Corte d’Assise, con centinaia di imputati e lunghe ed estenuanti udienze. Clima difficile, a tratti insostenibile: la sfida tra criminalità e Stato si percepisce palesemente. Eppure il Presidente della Corte, da uno sguardo o da qualche parola scambiata velocemente con Salvatore, uno degli imputati, giovane capo mafia, intuisce che forse con lui si può stabilire un contatto che vada al di là del freddo rapporto giudice-imputato.
Intuisce che dietro a un imputato – per quanto pluriomicida - c’è un uomo, dolorosamente rassegnato al proprio destino di ergastolano: “Presidente, se suo figlio nasceva dove sono nato io adesso era lui nella gabbia; e se io nascevo dove è nato suo figlio, magari ora facevo l’avvocato, ed ero pure bravo”. Il Giudice rimugina a lungo su queste parole e il giorno dopo avere firmato la sentenza che condanna Salvatore e tanti altri all’ergastolo (quindi “spegnendogli la vita, anche se dietro lo scudo della legge”), quasi irrazionalmente prende carta e penna e gli scrive, inviandogli “Siddharta” di Hermann Hesse.
Prende così il via a un carteggio che durerà 26 anni. “Fine pena mai” è la storia, vera, di questo carteggio, del rapporto epistolare quasi paradossale tra chi, Salvatore, ha ucciso, e chi lo ha giudicato, stabilendo che fosse troppo pericoloso per non essere privato della sua libertà per sempre.
A scrivere è un magistrato di grande prestigio, poi senatore per due legislature, che, partendo dalle angosciose esperienze di Salvatore nei vari carceri d’Italia, tocca svariati temi, dal senso profondo della pena (anche sotto il profilo dell’incostituzionalità dell’ergastolo o quantomeno dell’ergastolo ostativo), alla drammatica situazione delle nostre carceri, alla reale possibilità di rieducazione del condannato all’inumanità lacerante del regime del 41 bis: particolarmente toccanti, tra gli altri, i racconti di Salvatore del primo permesso premio dopo decenni di carcere duro (“non sapevo nemmeno camminare...fuori è tutto nuovo per me, le macchine, la roba che c’è nei negozi, la gente com’è vestita, anche il fatto di pagare con l’euro”) e della fine della relazione con Rosi, la ragazza che gli ha sempre dato la forza per andare avanti, seguendolo fedelmente per tutte le carceri, salvo poi accorgersi amaramente dell’impossibilità di avere un futuro e una famiglia con un ergastolano.
In definitiva un libro che affronta temi tanto coraggiosi quanto, in questi tempi manettari e giustizialisti, clamorosamente impopolari: averli affrontati proponendo una storia vera eppure così particolare, a tratti sicuramente commovente, fa di questo “Fine pena: ora” un grande libro.
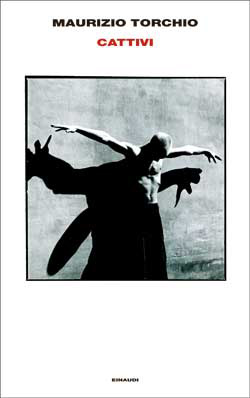 Cattivi
Cattivi
Maurizio Torchio
E’ una tentazione vecchia quanto l’essere umano, quella di ritenere che in quelle fortezze inespugnabili, più o meno lontane dal cuore delle nostre tranquille città, ci siano persone diverse da noi (i “cattivi”), che non ridono, non piangono, non hanno sentimenti, paure e progetti. Fa molto comodo pensarlo ma forse non è così e questo romanzo, incentrato sui “cattivi” nel senso etimologico di “prigionieri”, lo dimostra in modo crudo e senza pietismi.
E’un ergastolano, della cui vita ante carcere non si scopre quasi nulla ma che si è macchiato di gravissimi reati (prima un sequestro di persona a scopo di estorsione poi l’omicidio di un poliziotto penitenziario) a raccontare la vita del carcere, i rapporti con gli altri detenuti, le dinamiche, le gerarchie e le leggi che regolano la vita dei reclusi e di quella sorta di prigionieri in altra forma che sono le guardie.
Torchio si inserisce in quella classe di autori (Dostojevsky in testa, ovviamente e sia pure con le debite differenze) che, penetrando la psicologia del reo, creano una sorta di empatia, irrazionale e irresistibile, con il lettore. Non si riesce a odiare un uomo che, pur macchiatosi di terribili delitti (l’ultimo dei quali, l’omidicio del secondino, pressochè gratuito), rimane pur sempre tale, anche e a dispetto di un sistema, quello del carcere, teso proprio a spogliare di tutto, a “de-umanizzare” chi vi si trova invischiato.
Il libro scorre bene con una narrazione semplice e disadorna che ben si accompagna all’assenza di una vera trama ma sulla tensione di un’onda di dolore vivo (le pagine sui pestaggi o sulle visite dei parenti) e nel pudico accenno di un amore per la “principessa del caffè” (la donna sequestrata, con il quale il protagonista sogna irrazionalmente una vita al di fuori del carcere).
Un libro profondo, potente e a tratti giustamente brutale, che fa riflettere sulla coerenza tra una pena scontata in carcere e le finalità rieducative dettate dalla Costituzione.
 Un passo fuori dalla notte
Un passo fuori dalla notte
Raffaele Sollecito
Il caso dell’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher è stato uno dei casi giudiziari che più ha appassionato gli italiani, come al solito strenuamente divisi in colpevolisti e innocentisti non certo sulla base della conoscenza degli atti processuali ma delle impressioni, delle simpatie e antipatie e dei consueti (pre) giudizi sulle persone coinvolte.
Ora, in seguito alla sentenza della Cassazione che ha messo la parola fine alla vicenda processuale, annullando senza rinvio la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Firenze nel processo bis, Raffaele Sollecito racconta la sua verità (e la sua vita) e cerca di spiegare con quanta facilità si possa passare da studente universitario modello, prossimo alla laurea, a mostro sbattuto in prima pagina (e in carcere per quattro lunghissimi anni); e cerca nondimeno di spiegare, al contrario, con quanta difficoltà anche oggi che la sua estraneità all’omicidio di Meredith Kercher è stata accertata definitivamente, lui non possa camminare per la strada senza essere riconosciuto, guardato con sospetto, additato o senza che gli sia addirittura richiesto di posare per un selfie. Nemmeno la Cassazione può nulla contro lo stigma e contro la lettera scarlatta.
Si tratta quindi di un libro interessante anche per gli operatori del diritto non solo perché le fasi processuali sono raccontate con dovizia di particolari (a partire da quelle iniziali, in cui Sollecito – sulla scorta di un’inveterata e riprovevole prassi - viene reiteratamente sentito come “persona informata sui fatti”) ma soprattutto perché la stessa sentenza della Cassazione ha apertamente sottolineato come la risonanza mediatica internazionale della vicenda abbia influito negativamente su indagini caratterizzate oltre che da “clamorose defaillance investigative”, dalla “spasmodica ricerca di colpevoli da consegnare all’opinione pubblica”. Un tema che, nell’epoca dei talk show e dei processi in diretta tv, è di strettissima e drammatica attualità (si pensi alla nota vicenda del filmato del furgone di Bossetti).
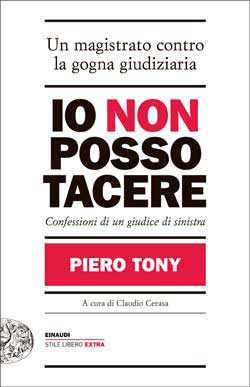 Io non posso tacere. Confessioni di un giudice di sinistra
Io non posso tacere. Confessioni di un giudice di sinistra
Piero Tony
Critica feroce dell’abuso della custodia cautelare “utilizzata come pressione psicologica quasi estorsiva”, analisi spietata delle supplenze della magistratura rispetto all’ignavia della politica, presa di distanza dalla spettacolarizzazione mediatica del processo, denuncia dell’impunità disciplinare dei magistrati etc. etc.
Tutto già visto, già sentito, forse non molto originale. Ma la novità è che questa volta la firma non è del giornalista schierato politicamente oppure dell’avvocato irriducibilmente garantista. Il tutto è invece contenuto in un centinaio di pagine al vetriolo scritte da un “certificato e autocertificato magistrato di sinistra”, aderente a Magistratura Democratica e che sostiene di essersi imposto una pensione anticipata, quand’era a capo della Procura di Prato, per non tollerare ulteriormente le storture del sistema, le connivenze e le responsabilità, ed anzi essere libero di denunciarle, “di non tacere”: Piero Tony, una vita spesa in magistratura con una brillante carriera in casi che hanno segnato la storia italiana, giudiziaria e non (Brigate Rosse, mostro di Firenze…), non lesina fendenti senza badare a pestare i piedi a tanti suoi ex colleghi (alcuni dei quali liquidati come più simili a “soubrette che a notai della giustizia”).
Certo, l’autore non nega che il sistema sia rovinato da poche mele marce e che la stragrande maggioranza dei magistrati lavora seriamente nel rispetto delle regole: non manca però di criticare duramente l’abuso delle intercettazioni (pur ritenute indispensabili) e del sistema dei pentiti, l’ottusità delle posizioni oppositive alla separazione delle carriere, alla responsabilità civile dei magistrati e al superamento del totem dell’obbligatorietà dell’azione penale.
Sin qui la pars destruens. Sarebbe ingiusto dimenticare la pars construens, che non manca ed è ben argomentata, in una prospettiva di riforma sia della magistratura sia del processo (che poi è quello che più ci interessa): così l’autore auspica, tra l’altro, l’introduzione del divieto di appello da parte del PM contro le sentenze di primo grado (come nei sistemi anglosassoni), l’abolizione dell’ergastolo, pena evidentemente incostituzionale, il rafforzamento della possibilità di beneficiare di pene alternative al carcere, da lasciare residualmente come “ultima opzione”, la riforma della prescrizione (“da interrompere con la sentenza di primo grado ma non per l’eternità, apparendo difforme a giustizia sottoporre un indagato a una spada di Damocle senza limiti solo per l’incapacità di un PM di provarne la responsabilità in tempi ragionevoli”) e così via con altre condivisibili proposte come l’amnistia e un’ampia depenalizzazione etc.
Vero è, tuttavia, che il tratto distintivo dell’opera, forse al di là anche delle intenzioni dello stesso Autore, è la durezza della critica nei confronti della magistratura e di come essa pieghi il codice di procedura penale alle proprie esigenze.
Dunque uno j’accuse formidabile ma, ci viene da aggiungere, desolatamente tardivo.
E’mai possibile che l’autore possa lanciare le sue accuse soltanto ora che è uscito dalla magistratura “perché altrimenti, per porsi al riparo dagli attacchi”, avrebbe “dovuto affrontare seri problemi di correnti associative”? Gli avrebbero messo il bavaglio, in altre parole?
Il particolare è inquietante dacché, tra politica occupata soltanto a vellicare i peggiori istinti dell’elettorato e magistratura almeno in parte ostaggio delle perverse logiche denunciate dall’autore, sembra restare soltanto l’avvocatura, con tutti i suoi innumerevoli problemi, a difendere lo Stato di diritto, mentre, come dice giustamente l’autore, “non è necessario essere avvocati per essere garantisti”. Non è necessario ma, allo stato dell’arte, evidentemente aiuta molto.





